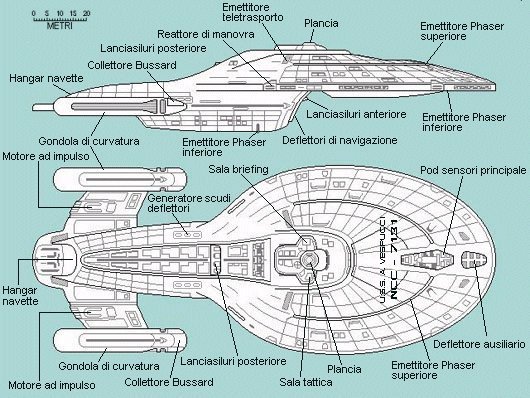
PROPULSIONE WARP
Caratteristiche:
•
Reattore Warp modello M/ARA Mark II
• Velocità di crociera: Warp 6
• Velocità massima: Warp 9,975
• Carburante (MRI): Deuterio Criogenico Supercritico
• Carburante (ARI): Anti-Idrogeno Criogenico Supercritico
• Elemento moderante della reazione M/AM: Dilitio
Cristallino di quinta fase
• Integrazione dinamica del carburante: Captatore Bussard 3
Funzionamento
dei motori Warp
La
parte propulsiva dei motori warp è situata nelle due gondole
gemelle ed è formata da una serie di bobine di campo di
curvatura (WFC, Warp Field Coil), su ognuna delle quali si trova
un sistema iniezione di plasma (PIS, Plasma Injection System);
inoltre ogni gondola dispone anche di un sistema di separazione
di emergenza formato da 10 gruppi di bulloni esplosivi che
possono allontanare la gondola in caso di emergenza alla
velocità di 30 m/s.
Le caratteristiche strutturali delle gondole sono simili a quelle
del resto della nave, in aggiunta abbiamo tre strati interni di
cortenide di cobalto che garantiscono la protezione contro gli
elevati stress strutturali causati dal campo warp.
Gli iniettori PIS (uno per ogni WFC) sono in duranide di arkenio
e contengono una struttura monocristallina di ferrocarbonite con
costrittori magnetici toroidali in serrite di nalgezio. I
controlli operativi e i dati delle letture di stato
dell'iniettore sono garantiti da dodici connessioni ridondanti
con il sistema di trasferimento dati (ODN, Optical Data Network)
della nave. I piccoli ritardi indotti dal trasferimento dati
sull'ODN sono automaticamente corretti da un apposito software
che garantisce alla sezione tecnica di operare in realtime sugli
iniettori. Il ciclo di apertura e chiusura degli iniettori varia
da 25 a 50 nanosecondi; ogni iniettore espone il WFC ad una
scarica di energia che viene convertita in campo warp.
I WFC sono gli
effettivi generatori del campo warp. Ogni emiciclo dei WFC misura
9,5 x 43 metri ed ha un nucleo in lega di tungsteno cobalto e
magnesio densificati avvolto da uno strato in cortenide di
verterio densificato elettricamente. Una bobina completa misura
quindi 21 x 43 metri con una massa di 34.375 tonnellate. Due set
completi di diciotto bobine l'uno hanno una massa di 1.230.000
tonnellate, che costituisce il 25% della massa complessiva della
nave. Quando è investito dal flusso di plasma, il cortenide di
verterio di una bobina provoca il trasferimento dell'energia dal
plasma al dominio subspaziale; i pacchetti quantici dell'energia
del campo subspaziale si formano a circa un terzo della distanza
tra la parte interna della bobina e quella esterna e irraggia
verso l'esterno della bobina.
L'effetto propulsivo è ottenuto da tre fattori.
In primo luogo la deformazione del campo è controllabile
sull'asse poppa-prua. Dal momento che gli iniettori emettono il
plasma in sequenza, i piani dei campi warp vengono creati di
conseguenza e premono l'uno sull'altro. Le forze cumulative dei
campi warp riducono la massa apparente della nave, imprimendo la
velocità desiderata. Il punto critico di transizione lo si ha
quando, per un osservatore esterno, la nave supera c; quando
l'energia del campo warp raggiunge i 1000 millicochranes, la nave
sembra che oltrepassi la barriera di c in un tempo minore del
tempo di Planck (1,3 -43 secondi), permettendo alla
nave di non avere mai una velocità pari a c. Le tre bobine più
a prua di ognuna delle due gondole operano con un leggero
spostamento di frequenza rispetto alle altre per rinforzare il
campo warp che contiene la sezione a disco e per facilitare la
creazione della simmetria del campo warp che permette il
movimento della nave.
In secondo
luogo la coppia di gondole permette di creare due campi
bilanciati che interagiscono per permettere alla nave di
manovrare. La nave può manovrare introducendo dei ritardi
nell'attivazione degli iniettori che modificano la geometria del
campo warp.
Infine la conformazione dello scafo si adatta perfettamente alla
conformazione del campo warp.
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
PROPULSIONE SUBLUCE (IMPULSO)
Caratteristiche:
•
Carburante: Deuterio Criogenico Bifasico
• Reattori ad impulso: 2
• Gruppi di bobine di propulsione: 8
• Direzioni di orientamento selettivo della propulsione: 8
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
SISTEMA DI TELETRASPORTO
Funzionamento:
Il traffico a
breve raggio da e per l'astronave passa generalmente attraverso
il teletrasporto, che permette di trasportare oggetti e persone
fino ad una distanza di 40.000 Km.
Nelle astronavi esistono dei dispositivi di teletrasporto per
persone e per oggetti, questi ultimi tuttavia possono essere
regolati per operare sia a risoluzione molecolare (cargo) sia a
risoluzione quantica (forme di vita).
Ogni coppia di teletrasportatori è concepita per condividere un
singolo pattern buffer, generalmente collocato nel ponte
inferiore.
All'esterno dello scafo di ogni astronave sono collocati degli
emettitori che incorporano degli scanner molecolari a lunga
distanza e delle bobine a transizione di fase e sono collocati in
modo da garantire una copertura sferica completa anche in caso di
malfunzionamento di alcuni singoli elementi.
Secondo il teorema di Elway, XXIII secolo, è possibile un
sistema di teletrasporto alternativo a quello descritto di
seguito, basato sul trasporto attraverso delle pieghe spaziali.
Benché agli inizi il concetto sembrava molto promettente, la
realizzazione pratica di un sistema di trasporto attraverso uno
spazio interdimensionale ripiegato ha rivelato che l'uso di
questo sistema causava dei danni cumulativi irreversibili nel
soggetto trasportato. I terroristi Ansata di Rutia IV facevano
uso di questa tecnica con un dispositivo che loro chiamavano
inverter.
Le operazioni di teletrasporto possono essere suddivise in cinque
gruppi, descritti di seguito; a causa della criticità di alcune
operazioni del trasporto, le regole operative della Flotta
Stellare richiedono la costante presenza di un ufficiale per la
supervisione ogni fase delle operazioni. NOTA: nelle
esemplificazioni che seguono viene considerata solamente una fase
di sbarco da una camera di teletrasporto ad una destinazione
remota. Altri tipi di operazioni implicano delle modifiche alle
sequenze di seguito indicate.
OPERAZIONI:
Scan
della destinazione e acquisizione delle coordinate: Durante questa prima fase il sistema di
teletrasporto acquisisce le coordinate di destinazione. Gli
scanner verificano il movimento relativo del luogo di
destinazione, la distanza e la presenza di condizioni ambientali
favorevoli al personale trasportato. Durante questa fase viene
eseguita una serie di verifiche diagnostiche di ogni singola
parte del sistema per assicurare un corretto funzionamento
dell'apparato.
Energizzazione
e smaterializzazione:
Gli scanner
molecolari ricavano in tempo reale un'immagine a risoluzione
quantica del soggetto da trasportare mentre le bobine principali
e le bobine di transizione di fase convertono il soggetto in un
flusso di materia disintegrata a livello subatomico.
Compensazione
Doppler nel pattern buffer: Il
flusso di materia viene immagazzinato nel pattern buffer che
permette al sistema di compensare lo spostamento Doppler tra la
nave e il luogo di destinazione. Il pattern buffer funge anche da
dispositivo di sicurezza in caso di malfunzionamento, permettendo
la rimaterializzazione del soggetto in un'altra unità di
teletrasporto della nave.
Trasmissione
del flusso di materia:
Il flusso di
materia viene trasmesso dagli emettitori della nave verso il
luogo di destinazione.
COMPONENTI
DEL SISTEMA:
Camera
del teletrasporto: È un volume di spazio ben
protetto all'interno del quale avviene il processo di
(s)materialzzazione. La piattaforma di trasporto è sopraelevata
per ridurre il pericolo di scariche elettrostatiche che si
possono verificare durante le procedure di trasporto.
Consolle: Questa postazione di controllo permette
all'ufficiale addetto di monitorare e dirigere le operazioni di
trasporto; inoltre è possibile bloccare manualmente la sequenza
automatica di operazioni in caso di emergenza.
Dispositivo
di controllo: Il computer dedicato per
queste operazioni si trova all'interno della camera di trasporto;
controlla ogni operazione del teletrasporto, comprese le sequenze
automatiche.
Bobine
primarie: Collocate al di sopra della
camera di trasporto, queste bobine creano il potente ACB che crea
una matrice spaziale all'interno della quale avviene il processo
di (s)materializzazione. Un secondo campo di forza mantiene il
soggetto all'interno dell'ACB; questa è una misura di sicurezza
in quanto la distruzione del campo ACB durante le prime fasi di
smaterializzazione può provocare il rilascio di notevoli
quantità di energia.
Bobine
di transizione di fase: Collocate
nella base della camera di trasporto, questi dispositivi,
generando un campo di manipolazione di quark a larga banda,
eseguono il processo di (s)materializzazione disaccoppiando
parzialmente le energie di legame delle particelle subatomiche.
Tutti i trasportatori abilitati al trasporto di personale sono
concepiti per operare a risoluzione quantica (necessaria per
trasportare con successo una forma di vita). I trasportatori
cargo sono generalmente ottimizzati per operare a livello
molecolare, ma possono essere riprogrammati per operare a livello
quantico.
Scanner
molecolari: Al di sopra di ogni
piattaforma si trovano quattro set ridondanti di scanner
molecolari di 0,0012µ collocati ad intervalli di 90° intorno
all'asse principale della piattaforma. Apposite routine di
controllo dell'errore escludono uno scanner nel caso in cui
fornisca dati discordanti con gli altri tre. Il guasto di due o
più scanner implicano un'interruzione immediata della procedura
di teletrasporto. Ogni scanner è spostato di 3,5 secondi di arco
dall'asse dell'ACB, consentendo una derivazione in tempo reale
dello stato quantico attraverso una serie di compensatori
Heisenberg dedicati. I dati degli stati quantici vengono ignorati
quando il trasportatore opera in modo cargo.
Pattern
buffer: Un dispositivo
superconduttore tokamak ritarda la trasmissione del flusso di
materia per permettere ai compensatori Doppler di applicare le
correzioni necessarie derivanti dalla differenza di velocità tra
il luogo di partenza e quello di arrivo. Un unico pattern buffer
è condiviso da ogni coppia di trasportatori. I regolamenti della
Flotta Stellare impongono che al momento del trasporto sia
disponibile almeno un altro pattern buffer di sicurezza. In
condizioni di emergenza, un pattern buffer è in grado di
ospitare l'intero flusso di materia in sospensione per circa 420
secondi prima che le informazioni registrate inizino a degradare.
Biofiltro: Utilizzato generalmente solamente dai trasportatori
delle astronavi, questo dispositivo analizza il flusso di materia
in arrivo alla ricerca di sequenze corrispondenti a forme di vita
batteriologiche e virali pericolose e note. Se vengono
individuate queste forme pericolose, il biofiltro le elimina dal
flusso di materia. Il biofiltro è in grado di riconoscere forme
di vita pericolose note.
Emettitori: Collocati all'esterno della nave, questi elementi
trasmettono i componenti dell'ACB e il flusso di materia da/per
le coordinate di destinazione. Gli emettitori comprendono anche
tre gruppi ridondanti di scanner molecolari a focalizzazione
virtuale a lunga distanza utilizzati durante le procedure di
imbarco. Utilizzando le tecniche di inversione di fase, questi
emettitori possono essere utilizzati anche per trasmettere
personale da/per l'interno della nave.
Scanner
per l'analisi della destinazione: Questi
dispositivi (dislocati all'esterno della nave) rilevano le
caratteristiche del punto di destinazione: coordinate, distanza,
moto relativo rispetto alla nave e condizioni ambientali. Le
coordinate di destinazione possono essere determinate anche dai
dispositivi di navigazione, tattici o di comunicazione. Per i
trasporti all'interno della nave, possono essere utilizzati i
sensori ambientali della nave stessa. Il personale della nave
può essere localizzato attraverso i comunicatori personali.
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
La plancia è il cuore del sistema operativo della nave e la sede di tutti i processi decisionali. Da qui possono essere controllati tutti i sistemi di bordo, con la possibilità di sostituire, in caso di emergenza intere sezioni divenute inoperative.

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
Acronimo
di PHASed Energy Rectification.
Sono il principale sistema di difesa della nave. Gli emettitori
sono di tipo XII, con una potenza di 7,2 megawatt ciascuno
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
•
Portata massima sensori ad alta definizione: 7 anni luce
• Portata massima sensori a media e bassa risoluzione: 21
anni luce
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci
Fonte: Archivio Tecnico della Flotta Stellare, a cura di Luigi Rosa